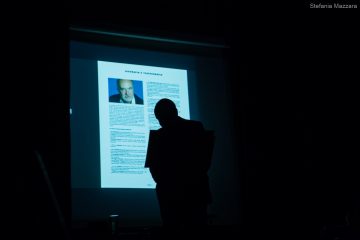#ATUPERTU CON ANTONIO CALENDA
LE PAROLE DEL MAESTRO
Avevo 12 anni quando vidi l’Otello con Del Monaco al Teatro dell’Opera di Roma. Mi conquistò. Iniziai a studiare canto e a seguire l’opera. Ma a 18 anni capii che la lirica non faceva per me. Volevo iscrivermi all’Accademia per recitare, ma mio padre si oppose.
Dopo essermi laureato in Giurisprudenza iniziai a lavorare e con i primi stipendi, affittai una cantina.
Fu quella la culla del Teatro Centouno, fondato insieme con Virginio Gazzolo, Gigi Proietti, Leo De Berardinis e Piera Degli Esposti.
Teatro sperimentale, teatro d’avanguardia. Un’impresa difficile e faticosa, senza possibilità di accesso ai fondi pubblici. Facevamo tutti un doppio lavoro. Io e Gigi abitavamo insieme, in una stanza al convento dei preti ortodossi, e ci svegliavamo ogni mattina al canto dei cori russi. Era dura, però la nostra voglia di innovare, di creare qualcosa di autenticamente originale, ci faceva superare ogni sacrificio.
Il Teatro è una necessità intrinseca alla natura dell’uomo: la necessità di essere collettività, di porsi di fronte agli altri come di fronte a se stessi, di farci domande senza necessariamente pretendere di trovare risposte ma, piuttosto, accettando le dicotomie che si palesano di fronte a noi.
Quello del teatro è un rituale sacro e religioso ma contemporaneamente civile, proprio perché coinvolge la collettività. E in tal senso, io credo che l’interprete debba rinunciare a ogni vanità e celebrare generosamente questo rito assolvendo alla sua missione del dire, del farsi veicolo, megafono.
Il Teatro esiste nell’hic et nunc per poi svanire e sublimarsi nell’assenza, consegnato alla memoria del singolo, dei singoli, una memoria collettiva, amplificata, a volte “distorta”. Ma la sua essenza, la sua eco emotiva si sostanzia nella sensibilità di colui che assiste, ed è a questo che non si deve rinunciare.
Foto di Stefania MAZZARA